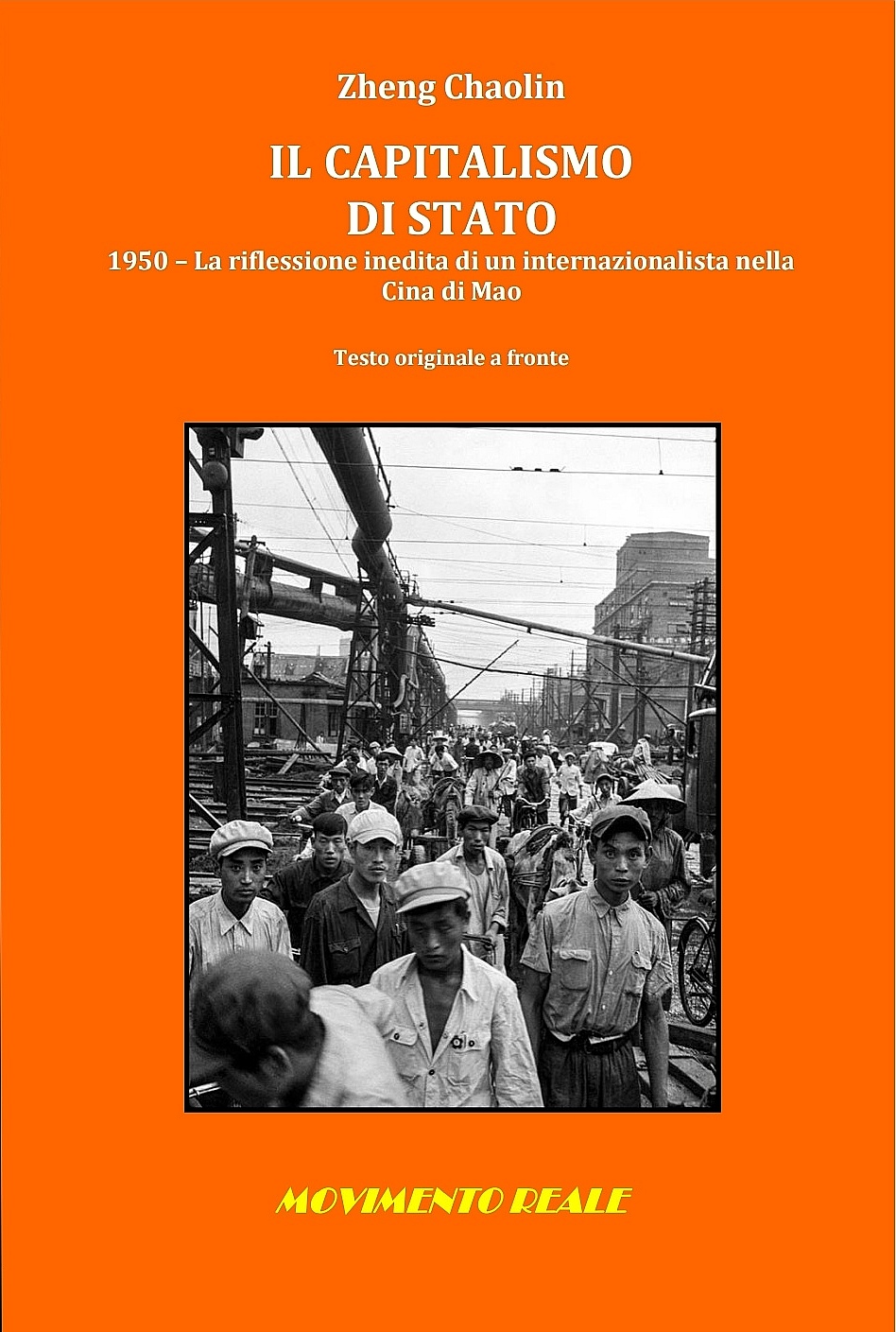ZHENG CHAOLIN E LA TEORIA DEL CAPITALISMO DI STATO – VIII
Dalla postfazione al testo di Zheng Chaolin Il capitalismo di Stato, Movimento Reale, Roma, gennaio 2023
Nella sua trattazione sul capitalismo di Stato Zheng Chaolin non sbaglia nel ritenere che l’effettiva presenza di un potere rivoluzionario proletario, in uno o più Paesi, sia più importante «in un primo momento» del grado di estensione della nazionalizzazione e della pianificazione. Ed è vero che la nazionalizzazione e la pianificazione, senza la dittatura del proletariato, non rappresentano altro che capitalismo di Stato. Tuttavia l’importanza della dittatura del proletariato, a differenza di quanto sembra pensare Zheng, non risiede nelle sue specifiche forme di rappresentanza, quanto, come abbiamo già in precedenza sottolineato, nella capacità di procedere nella demolizione dei rapporti capitalistici di produzione.
La dittatura del proletariato rappresenta una forma politica espressione di un rapporto di forza tra le classi. Un rapporto che vede il proletariato elevarsi a classe dominante per procedere all’eliminazione delle classi in generale, quella borghese e la propria. Se può essere considerata una “democrazia” in senso “aristotelico”, ovvero come “governo dei non possidenti”, la dittatura del proletariato non deve essere necessariamente intesa né come “governo della maggioranza” – in quanto il proletariato può anche non costituire la maggioranza assoluta della popolazione –, né come una forma politica che – per quanto tendenzialmente espansiva – sia sempre soggetta alle decisioni delle maggioranze che temporaneamente si possono formare all’interno della classe di cui rappresenta gli interessi generali.
In circostanze particolari, determinate dalle alterne vicende della lotta rivoluzionaria mondiale, gli spazi della democrazia formale all’interno della dittatura del proletariato possono ridursi notevolmente senza per questo alterare necessariamente la sua natura di classe, così come la limitazione o la forte riduzione della democrazia interna alla classe dominante – come avviene per esempio con il fascismo, o nei regimi pseudo-socialisti a partito unico – non rappresenta un venir meno della natura di classe della dittatura borghese.
Come scrive Bordiga:
La dittatura [del proletariato] è definita dalla forza e dalla direzione di questa forza; non si deve dire che essa costruisce il socialismo a condizione di essere la giusta dittatura, ma che essa è la vera dittatura proletaria quando cammina verso il comunismo.[1]
Con l’occhio rivolto all’esperienza russa, Zheng Chaolin ritiene inoltre che la nazionalizzazione e la pianificazione sotto la dittatura del proletariato rappresentino tout court l’economia nel periodo di trasformazione, ma in realtà se nei Paesi capitalisticamente maturi queste misure prese dal potere proletario non rappresentano altro che un primo passo in direzione della socializzazione, in Russia costituirono la gestione del capitalismo di Stato da parte della dittatura del proletariato, fino al definitivo snaturamento di questa dittatura. Dunque, non si può convenire con Zheng quando afferma che la Russia sovietica avrebbe rappresentato «per alcuni anni dopo la Rivoluzione d’Ottobre» uno «Stato operaio nel periodo di transizione», dal momento che il Paese non poteva allontanarsi dai rapporti capitalistici di produzione ma era costretto anzi a incrementarli. Così come non si può convenire con il rivoluzionario marxista cinese quando ritiene che il passaggio dallo Stato operaio al capitalismo di Stato sia iniziato nel 1923 per concludersi addirittura nel 1937, quando, a nostro avviso, quel processo – per quanto l’annientamento degli ultimi rivoluzionari sia stato perpetrato relativamente tardi – si era già sostanzialmente concluso proprio nel momento in cui Zheng lo fa iniziare.
L’economia russa non è mai stata un’economia di transizione al socialismo. Sotto questo aspetto, l’elaborazione di Zheng rivela ancora l’influsso del trotskismo, dal quale formalmente non prenderà mai completamente le distanze, ed effettivamente, nella sua trattazione, il collegamento tra la controrivoluzione in Russia e la mancata rivoluzione internazionale non viene sempre messo in sufficiente evidenza. Eppure, a differenza del trotskismo e anche di buona parte della sinistra rivoluzionaria ancora negli anni in cui redigeva il suo studio, Zheng Chaolin è stato in grado di individuare con notevole precisione il “nemico non visto”[2], è stato cioè in grado di identificare nel capitalismo di Stato e non nella borghesia contadina o nei nepman la base sociale della controrivoluzione stalinista.
Sebbene in alcuni punti della sua trattazione Zheng Chaolin sembri sottintendere – probabilmente influenzato dalle tesi di Bucharin – che la concorrenza all’interno del quadro “nazionale” del capitalismo di Stato sia completamente sostituita dal monopolio e che conservi la propria esistenza esclusivamente all’esterno, come concorrenza tra nazioni a monopolio statale, in altri passaggi il rivoluzionario cinese riconosce correttamente l’esistenza di questa concorrenza sia all’interno dei “blocchi” sovranazionali – in cui alcune contraddizioni, per sua stessa ammissione, per quanto “attutite” non sono però eliminate[3] – sia esaminando lo scontro tra le frazioni borghesi all’interno dei capitalismi statali delle singole “democrazie popolari” nel rapporto con il capitalismo russo, il quale, per quanto non venga esplicitamente definito tale, rivela le caratteristiche di una potenza imperialista.
Nella trattazione di Zheng – e ricordiamo che l’autore scrive nel 1950 – le “borghesie di Stato” delle varie “nuove democrazie”, tra le quali, oltre ai Paesi dell’Europa orientale come Polonia, Ungheria, ecc., l’autore annovera anche la Cina maoista, si dividono essenzialmente in due gruppi: le frazioni che accettano di condividere lo sfruttamento della classe operaia del proprio Paese con la potenza russa, pagando a quest’ultima il suo tributo imperialistico di plusvalore, e le frazioni alle quali la forzata immissione nella sfera d’influenza russa rimane stretta, e che premono per “autonomizzarsi”. Si tratta indiscutibilmente di una valida disamina dei rapporti tra gli interessi rappresentati dall’ideologia “titoista” e l’URSS, nonché di una solida impostazione marxista in grado di dare spessore all’analisi degli eventi che si sarebbero verificati nell’arco di pochi anni in Germania orientale, in Polonia e in Ungheria, dove nel novembre del 1956 le frazioni del capitalismo di Stato “democratiche”, facenti capo a Imre Nagy, cercarono di contendere all’imperialismo russo il monopolio dello sfruttamento dei proletari ungheresi in rivolta o al limite di trattare per ottenere maggiori vantaggi dal suo esercizio; con le prime che si prodigarono nel tentativo di devitalizzare e disarmare i consigli operai mentre il secondo era impegnato a schiacciarli con le sue divisioni di panzer.
Continua…
NOTE
[1] Danza di fantocci: dalla coscienza alla cultura, da Il programma comunista, n. 12 del 1953.
[2] Cfr. M. Ingrao, Il nemico non visto – Alle radici della controrivoluzione stalinista, Prospettiva Marxista, Busto Arsizio (VA), 2009.
[3] «… il modello dell’imperialismo di Lenin si fondava su una concezione sensibilmente diversa [da quella di Bucharin] del capitalismo nazionale. Benché anch’egli sottolineasse la trasformazione del capitalismo del laissez-faire nel capitalismo monopolistico, osservando che “la cosa principale in questo processo è lo spostamento della… libera competizione”, era però considerevolmente meno incline a concludere che la competizione e l’anarchia della produzione fossero state eliminate dall’economia nazionale. Egli sosteneva piuttosto che la monopolizzazione di parte dell’economia intensificava “l’anarchia inerente alla produzione capitalistica come una totalità”. Egli vedeva un quadro variegato – “qualcosa di effimero, un misto di libera competizione e di monopolio” – e concludeva che “i monopoli che sono emersi dalla libera competizione non eliminano quest’ultima ma esistono al di sopra di essa ed accanto ad essa e danno origine perciò a numerosi antagonismi intensi, acutissimi…”. Per Lenin l’idea che la trustificazione potesse abolire le crisi interne era una “favola diffusa da economisti borghesi”». S. F. Cohen, Bucharin e la rivoluzione bolscevica, Feltrinelli, Milano, 1975, p. 45.