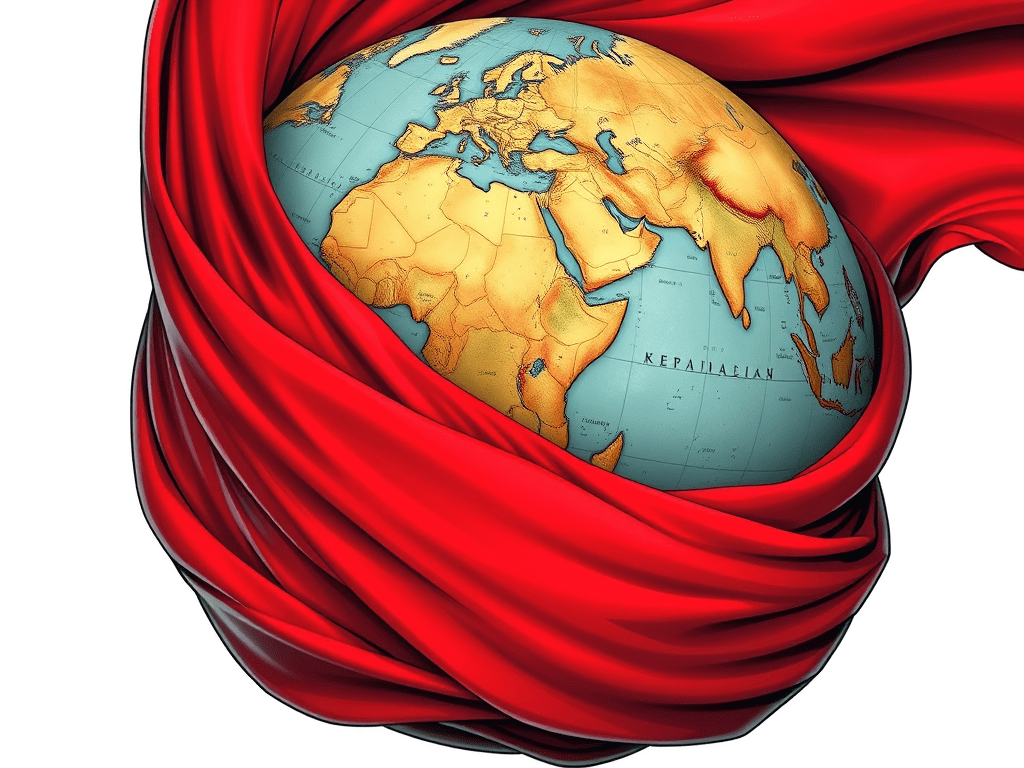LA MATURAZIONE IMPERIALISTICA DEL CAPITALISMO E I COMPITI DELL’INTERNAZIONALISMO PROLETARIO – VI
Articolo pubblicato nel n. 125 di Prospettiva Marxista, maggio 2025.
Se le periodizzazioni schematiche possono avere un senso per gli storici accademici, non possono averne per la teoria e per la politica rivoluzionaria del proletariato. Troppo spesso le demarcazioni meccaniche rappresentano il tentativo di ergere un illusorio muro difensivo ideologico, oppure quello di tracciare una facile scorciatoia per aggirare lo sforzo di analizzare i fenomeni nella loro complessità. Le necessarie generalizzazioni formulate da Marx, da Engels o da Lenin, sono sempre state da loro stessi sottoposte ad altrettanto necessarie precisazioni, approfondimenti, specificazioni di ordine storico, sociale, geografico. In ciò risiede la sostanziale differenza tra una “filosofia della Storia” e la concezione materialistica della storia.
Per il marxismo le generalizzazioni sono sempre il prodotto di un’analisi rigorosa della dialettica complessità del reale e mai il tentativo aprioristico di sopprimere nell’idea quella stessa complessità.
Non è tracciando un’immaginaria linea di demarcazione tra un prima e un dopo dei fenomeni sociali – una linea invalicabile e definitiva, e, in quanto tale, fallace nella sua pretesa di assolutezza – che la politica rivoluzionaria può difendersi efficacemente dal costante assedio delle infiltrazioni ideologiche borghesi. Non si tratterebbe d’altro che di una sicurezza illusoria confortata soltanto da una penetrabilissima barricata di cartapesta.
In questo senso la delimitazione dell’epoca in cui il proletariato poteva appoggiare lotte di liberazione nazionale sconta troppo spesso, persino in campo internazionalista, la poco dialettica tentazione di stabilire questi confini rigidi e immutabili, queste “date metafisiche” che violentano la natura dialettica delle generalizzazioni prodotte dall’applicazione del metodo marxista.
Quando Marx, a consuntivo della tragica esperienza della Comune di Parigi del 1871, denunciava l’esaurimento della capacità del dominio borghese di «travestirsi con una uniforme nazionale», non intendeva affermare che il carattere progressivo delle guerre nazionali fosse tramontato da allora e per sempre in ogni angolo del globo. Intendeva piuttosto tratteggiare una potente generalizzazione storica in grado di stabilire quale classe determinasse ormai il contenuto fondamentale della nuova situazione, indicando al proletariato l’orientamento complessivo dell’indispensabile analisi di ogni specifico contesto sociale.
Quando Lenin definendo l’epoca della maturazione imperialistica del capitalismo, tracciava approssimativamente tra prima e dopo il “1870” il confine storico oltre il quale i compiti della rivoluzione nazionale avevano perso la loro attualità in “Occidente”, e fra Occidente e Oriente il confine geografico oltre il quale, anche dopo il 1870, questa attualità si era in una certa misura conservata, non negava, ad esempio, l’esistenza di una irrisolta questione nazionale nell’occidentale Irlanda. E d’altro canto non riconosceva un ruolo rivoluzionario all’orientale borghesia russa o polacca. Piuttosto, riteneva che fosse il proletariato a doversi assumere determinati compiti ormai difficilmente realizzabili da una borghesia già impegnata ad affrontare il suo antagonista storico.
Quando Rosa Luxemburg, nel 1916, rimproverava a Lenin di non tenere sufficientemente conto del fatto che nella nuova epoca le questioni nazionali erano impugnate dalle grandi potenze, non formulava una generalizzazione feconda ma uno schema rigidamente astratto. La strumentalizzazione delle questioni nazionali da parte delle grandi potenze in chiave reazionaria o nell’ottica delle loro reciproche rivalità era veramente una caratteristica specifica della nuova epoca? Non era stata forse già individuata da Marx ed Engels a proposito delle rivendicazioni delle piccole nazionalità slave brandite dalla reazione zarista nel 1848; così come a proposito dell’ingerenza della Francia bonapartista e dell’Inghilterra dei Russell e dei Palmerston nel Risorgimento italiano, ovvero nel pieno della fase ascendente del capitalismo sulla scala storica mondiale?
Lo stesso malcompreso e bistrattato Lenin non negava affatto l’esistenza di un utilizzo strumentale delle rivendicazioni nazionali nel gioco delle potenze imperialiste[1]. Tuttavia, a differenza di Luxemburg, Lenin non pretendeva di sostituire con uno schema aprioristico la necessaria analisi materialistica del contesto specifico, presupposto irrinunciabile della definizione di un programma politico rivoluzionario. Per Lenin la sempre presente strumentalizzazione delle questioni nazionali irrisolte da parte delle potenze rivali non era ancora, nel secondo decennio del XX secolo, l’elemento predominante in ogni contesto di quella specifica fase della maturazione imperialistica, ma accentuava semmai la necessità della piena indipendenza politica dalla borghesia da parte del proletariato rivoluzionario all’interno dei processi di liberazione nazionale, quando non la direzione di quegli stessi processi, ed in ogni caso non poteva costituire un alibi per la rinuncia al riconoscimento del diritto di autodeterminazione da parte del proletariato cosciente di un paese che ne opprimesse nazionalmente un altro.
È sulla base di una specifica analisi materialistica che è possibile oggi pervenire alla generalizzazione che vede nell’intervento delle potenze dell’imperialismo nelle residue questioni nazionali l’elemento assolutamente predominante in ogni contesto. A patto che rimanga una generalizzazione sottoposta al continuo vaglio del confronto con la mutevole complessità del reale e non uno schema aprioristico valido da qui all’eternità.
L’esperienza storica, grossomodo dagli anni Venti ai primi anni Settanta del XX secolo, ha tragicamente dimostrato che proprio laddove un proletariato di una certa consistenza non è riuscito ad assumere la direzione di processi di rivoluzione in permanenza nei paesi dominati, oppure laddove le sue avanguardie sono state ferocemente massacrate dalla borghesia nazionalista, quest’ultima, assumendo le più disparate forme politiche – comprese quelle pseudosocialiste –, si è rivelata sufficientemente forte e autonoma da riuscire a destreggiarsi tra le rivalità delle grandi potenze e ad approfittare del loro appoggio interessato per raggiungere l’indipendenza politica. Quando, sulla base di questi presupposti, la borghesia coloniale è riuscita a liberarsi pienamente dalla dipendenza politica dalla metropoli, ha avuto la possibilità – grazie ad una combinazione di centralismo politico e di sviluppo industriale – di dosare il grado di dipendenza economica da quelle stesse potenze dell’imperialismo dalle quali si è liberata. Non è un caso se proprio da questi nuovi Stati indipendenti sono sorte quelle che oggi si configurano come potenze in ascesa dell’imperialismo, come India e Cina.
Tuttavia, se il contesto imperialistico ha in generale accelerato lo sviluppo del capitalismo e dell’industria nei paesi dominati, rafforzando socialmente entrambe le moderne classi antagonistiche e ponendo alcune borghesie di fronte al problema storico delle rivendicazioni di un già robusto movimento operaio (problema dalla “soluzione” del quale, una volta esclusa l’opzione della direzione proletaria di una rivoluzione “doppia”, dipendeva la possibilità della borghesia nazionale di portare a termine alla meglio processi di rivoluzione democratico-borghese), in certi casi ha invece drasticamente condizionato questo sviluppo. Al sorgere della fase imperialistica del capitalismo non sempre le cause dell’imposizione di forme di dominio coloniale o semicoloniale rispondevano direttamente a ragioni economiche. Se le risorse naturali di cui disponeva il territorio occupato non erano ancora note o non costituivano ancora materie prime per l’industria della madrepatria, il controllo politico e militare di un territorio rispondeva inizialmente più all’esigenza di sottrarre quel territorio (e le sue potenziali ricchezze) al controllo delle potenze rivali per esigenze strategiche – difensive od offensive – e per non rimanere indietro nella contesa per la spartizione, piuttosto che all’esigenza di un immediato sfruttamento economico Se poi in questi territoriil capitalismo imperialistico veniva a scontrarsi con modi di produzione estremamente più arretrati (spesso al livello di economie di sussistenza) – ad esempio nell’Africa Subsahariana e in Medio Oriente – la brutalità della collisione storica, in conformità con la sua intrinseca natura sociale, doveva necessariamente crescere in proporzione inversa al livello di sviluppo che l’imperialismo incontrava sul suo cammino e in proporzione diretta alla quantità di ricchezze naturali che il suo crescente appetito industriale veniva man mano scoprendo e reclamando. Una brutalità che si estrinsecava anche nella ridotta quantità di investimenti in capitale costante e nell’estorsione di plusvalore assoluto dalle popolazioni assoggettate. Rimaste a lungo ai margini dei principali flussi mondiali di esportazione di capitali, il percorso attraverso il quale queste regioni sono state comunque innegabilmente trascinate all’interno dei rapporti capitalistici di produzione non si è tradotto però in un rafforzamento sociale e politico delle borghesie e del proletariato locali in misura sufficiente a garantire loro un ruolo autonomo nel confronto con le centrali imperialistiche. Anche quando i paesi di queste regioni hanno raggiunto l’indipendenza formale, non sono stati in grado di emanciparsi da una condizione di estrema fragilità interna e di sostanziale dipendenza economica, finanziaria – e, seppure in maniera indiretta, anche politica – dalle potenze dell’imperialismo. Una dipendenza che nulla ha a che vedere con il concetto di “neocolonialismo”. Se alcuni di questi paesi sono stati immobilizzati, nell’ambito della divisione internazionale del lavoro e dei rapporti di scambio internazionali, al rango di “riserve” di materie prime o di forza-lavoro migrante, altri sono diventati opulente economie parassitarie, legate alla rendita derivante da terreni ricchi di idrocarburi “coltivati” come monocolture (una “lama a doppio taglio” nel rapporto con i paesi di più antica e radicata industrializzazione); un’esigua minoranza di altre entità nazionali, perlopiù situate nelle “zone di faglia” dell’imperialismo, non è peraltro riuscita a costituirsi in Stato-nazione.
Si può vedere in ciò un motivo sufficiente per considerare ancora storicamente progressive le “rivendicazioni nazionali” di queste entità o addirittura per gratificarle della qualifica di “lotte antimperialiste”?
Scrive Marx:
In tutte le forme di società è una produzione determinata che assegna rango e influenza a tutte le altre, come del resto anche i suoi rapporti assegnano rango e influenza a tutti gli altri. È una luce generale in cui sono immersi tutti gli altri colori e che li modifica nella loro particolarità. È un’atmosfera particolare che determina il peso specifico di tutto ciò che da essa emerge.[2]
L’imperialismo è oggi questa «luce generale», questa «atmosfera particolare» che «assegna rango e influenza» ad ogni altro rapporto esistente sul mercato mondiale capitalistico. Dunque, l’imperialismo non è né può essere una condizione “esterna” a nessun paese, a nessun’area del globo. Non ha confini geografici o politici, ed è perciò fuorviante qualsiasi distinzione tra “paesi imperialisti” e non. Nel linguaggio dell’opportunismo terzomondista la qualifica di “imperialista” implica un giudizio di valore tra le diverse aree e paesi del mercato mondiale, tra i diversi Stati di cui si servono le sezioni nazionali di una borghesia che è ormai storicamente imperialista – e dunque reazionaria – nel suo complesso, a livello globale. L’imperialismo viene identificato esclusivamente con le centrali, con le potenze dell’imperialismo, in modo da poter affermare esplicitamente che, se un paese economicamente avanzato è “imperialista”, e dunque reazionario, un altro paese, in quanto meno sviluppato può non esserlo, mentre una borghesia nazionale che non possegga tutti gli attributi dello Stato-nazione non lo è affatto. Se ad esempio l’“Amerika” è universalmente riconosciuta come un “imperialismo”, difficilmente l’Ucraina e l’Iran vengono definiti tali dagli opportunisti, e, se la borghesia curda o palestinese viene definita “antimperialista” (diluendola nella comoda categoria di “popolo”), la Russia o la Cina vengono invece definite “imperialismi emergenti” con il subdolo intento di contrapporre il presunto carattere positivo o non ancora del tutto negativo della loro relativa “giovinezza” alla marcescenza delle vecchie metropoli (sempre “occidentali”). Indubbiamente esistono differenze di «rango» e «influenza» fra i paesi immersi nell’«atmosfera particolare» dell’imperialismo. Si tratta però di differenze quantitative e non qualitative, di «peso specifico» nello sviluppo economico e nella forza politica determinata in definitiva dal primo; di differenze che si manifestano all’interno di un medesimo contesto globale, determinate da questo stesso contesto e che non implicano alcun passaggio storico “incompiuto”. Non è compito degli internazionalisti avallare, sostenere o appoggiare scontri che riguardano essenzialmente la ridefinizione del rango e del peso specifico degli Stati borghesi all’interno del quadro imperialistico. Anche laddove le sue organizzazioni politico-amministrative non riescono a imporre la propria esclusiva e piena sovranità su un territorio nazionale, o a svincolarsi da condizioni di dipendenza, siamo oggi in presenza di una borghesia dell’imperialismo, di una borghesia la cui posizione sociale è garantita dalla dipendenza dalle centrali imperialistiche, di una borghesia la cui debolezza è il prodotto dell’imperialismo tanto quanto la forza delle borghesie che sono invece riuscite a occupare un posto relativamente autonomo nel sistema degli Stati. Non tutte le borghesie riescono a darsi uno Stato e non tutti gli Stati sono potenze, ma tutti sono inestricabilmente inseriti nella trama dell’imperialismo, per questo è preferibile parlare di borghesie, di Stati e di potenze dell’imperialismo.
Respingendo gli artifizi semantici degli opportunisti del genere: “guerre intercapitalistiche”, è dunque possibile definire come guerre imperialiste o interimperialiste tutte le guerre dell‘imperialismo, tutte le guerre tra Stati dell’imperialismo, che siano o meno potenze, operando una distinzione con le guerre imperialistiche mondiali qualora almeno due grandi potenze si scontrino direttamente sul terreno militare coinvolgendo inevitabilmente la loro rete di alleanze. Respingendo invece le semplificazioni ad effetto del genere: “Terza guerra mondiale a pezzi”, è bene specificare che soltanto a posteriori è possibile considerare come parte di guerre imperialistiche mondiali quei conflitti che iniziano come scontro bellico tra Stati che non sono – o non sono entrambi – potenze dell’imperialismo, ma che successivamente si trasformano o vengono assorbiti nello scontro diretto tra grandi potenze[3].
Se è vero che non esiste un “dentro” ed un “fuori” l’imperialismo è altresì innegabile che l’imperialismo incancrenisce ed alimenta condizioni di oppressione nazionale. A tal proposito, anche in ambienti che si riferiscono sinceramente all’internazionalismo proletario, esiste la tendenza a semplificare eccessivamente i termini dell’atteggiamento comunista nei confronti della questione nazionale nell’epoca della maturità imperialistica del capitalismo, affermando, ad esempio, che nella fase attuale «la questione è sempre di classe e mai di nazione».
In realtà, se si aderisce conseguentemente alla concezione materialistica della storia, non può esistere e non è mai esistita nella società divisa in classi questione politica che non sia essenzialmente questione di classe. Dunque, anche le questioni nazionali erano e sono questioni di classe, che coinvolgono lo scontro delle classi e che, nella società capitalistica, in un modo o nell’altro, riguardano la classe operaia. Quando il movimento operaio rivoluzionario ha ritenuto necessario prendere posizione in merito a determinate rivendicazioni nazionali appoggiandole lo ha fatto precisamente in considerazione del loro contenuto e delle loro implicazioni di classe: sia che si trattasse per una classe operaia in formazione di allearsi ad una classe borghese nazionale ancora rivoluzionaria contro il localismo antiunitario di classi feudali e semifeudali autoctone o contro dominazioni straniere che frenavano lo sviluppo dei moderni rapporti capitalistici – ovvero del terreno di scontro per la lotta delle moderne classi sociali; sia che si trattasse di tentare di estirpare le radici del sentimento di ostilità nazionale tra i proletari dei paesi oppressi e quelli dei paesi oppressori.
A rigor di termini marxisti, per il proletariato la questione “è sempre di classe” in ogni fase dello sviluppo capitalistico. La formulazione summenzionata è quindi inesatta e fuorviante per almeno due motivi: da un lato, assumendo nella fase attuale l’esistenza del solo elemento classista e negando quello nazionale parrebbe ammettere implicitamente che in una precedente fase storica una questione potesse configurarsi come puramente nazionale senza essere anche essenzialmente di classe, il che implicherebbe una inaccettabile concessione all’ideologia nazionalista; dall’altro il rischio è lo scivolamento verso una posizione che può giungere di fatto a negare o trascurare l’esistenza di situazioni di oppressione nazionale nell’epoca imperialistica, prestando il fianco alle rituali quanto strumentali accuse di “indifferentismo” lanciate dall’opportunismo terzomondista.
In effetti, venuta storicamente meno, allo stato attuale, l’esigenza di appoggiare rivendicazioni nazionali nella prospettiva di un’accelerazione dello sviluppo delle forze produttive – in un contesto in cui i rapporti capitalistici di produzione sono ormai sostanzialmente dominanti in ogni angolo del globo e in cui le basi materiali per il loro superamento sono più che sufficienti alla scala mondiale – rimane per l’internazionalismo proletario la necessità inaggirabile di fare i conti con le situazioni di oppressione nazionale tuttora esistenti e che continuamente sorgono e risorgono sul terreno dell’imperialismo, in tempi di “pace” come in tempi di guerra.
Ciò che distingue i comunisti internazionalisti dai socialimperialisti e dai terzomondisti non è quindi il riconoscimento dell’esistenza dell’oppressione nazionale ma la risposta politica che, nell’epoca della piena maturazione imperialistica del capitalismo, a tale condizione di oppressione viene fornita.
Sulla base di un’analisi materialistica del complessivo quadro imperialistico mondiale e delle sue specifiche articolazioni locali è possibile affermare che attualmente nessuna delle borghesie dei territori in cui è in atto un’oppressione nazionale è in grado di esprimere la forza o la volontà necessarie a svincolarsi significativamente dalla subordinazione agli interessi delle potenze dell’imperialismo in contrasto. Che il proletariato vittima di queste residuali situazioni di doppia oppressione, di classe e nazionale, non è purtroppo attualmente in grado di porsi alla testa di un processo di rivoluzione “doppia” o “in permanenza” e che solo l’intervento rivoluzionario del proletariato delle metropoli o regionale può condurre ad una risoluzione di tali questioni che non sia il portato di guerre, spartizioni e ridefinizioni territoriali imperialistiche[4].
In questo contesto, riafferma la sua piena e incontrovertibile validità quanto scritto da Marx nel “lontano” 1847:
La vittoria del proletariato sulla borghesia è in pari tempo la vittoria sui conflitti nazionali e industriali che oggigiorno creano l’ostilità tra i diversi popoli. La vittoria del proletariato sulla borghesia è quindi in pari tempo il segnale della liberazione di tutte le nazioni oppresse.[5]
In conclusione, senza pretendere di esaurire l’argomento o di fornire facili e definitive “formule magiche” ma con l’intento di stimolare un confronto costruttivo negli ambienti autenticamente marxisti, riteniamo utile e opportuno sintetizzare gli attuali compiti dell’internazionalismo proletario in merito alla “questione nazionale” grossomodo come segue:
a. riconoscimento dell’esistenza di condizioni di oppressione nazionale, loro denuncia e lotta contro le guerre imperialistiche della propria borghesia per mantenerle, inasprirle, estenderle o imporle ex-novo;
b. rifiuto di appoggiare qualsiasi forza politica espressione di una borghesia nazionale;
c. riconoscimento da parte del proletariato cosciente dei paesi che ne opprimono altri del diritto borghese all’autodeterminazione nazionale dei paesi oppressi, come strumento tattico per eliminare i motivi di sfiducia e ostilità da parte dei proletari di questi paesi e per contrapporsi inequivocabilmente alla borghesia di casa propria;
d. collaborazione con ogni tentativo di stabilire collegamenti tra il proletariato cosciente delle nazionalità oppresse e di quelle che opprimono, allo scopo di pervenire all’unità politica del proletariato regionale e, tendenzialmente, mondiale;
e. appoggio ad eventuali organismi e formazioni del proletariato con autonomo carattere di classe nel corso di una guerra o di un’occupazione imperialistica, volti ad organizzare la difesa fisica dei lavoratori dalle violenze della borghesia esterna e interna;
f. lotta contro le alleanze economiche, politiche e militari della borghesia di casa propria e contro i conglomerati imperialistici, attuali o potenziali;
g. inflessibile battaglia teorica e politica contro l’opportunismo, il campismo e il socialsciovinismo terzomondista, per impedire che tali ideologie attecchiscano presso il proletariato delle metropoli imperialistiche e per indicare, nella misura in cui le condizioni lo consentono, ad eventuali minoranze coscienti dell’intero proletariato delle regioni all’interno delle quali persistono sacche di oppressione nazionale, la strada della solidarietà internazionalista e della rivoluzione proletaria con compiti direttamente comunisti, come unica soluzione non imperialistica per porre fine anche a questa forma di oppressione.
NOTE
[1] Nel 1915, ad esempio, il dirigente bolscevico pur affermando che l’unico reale «elemento nazionale» nella Prima guerra mondiale era costituito dal conflitto della Serbia contro l’Austria, riconosceva altresì che la guerra serba non era «isolata» ma «collegata con la guerra europea e con avidi scopi di rapina dell’Inghilterra, della Russia, ecc.,» e che dunque il fattore nazionale serbo nella guerra imperialistica non aveva «alcuna seria importanza». Lenin, Il fallimento della Seconda Internazionale, in Il socialismo e la guerra, Lotta comunista, Milano, 2006, pp. 68. Un paio di anni dopo Lenin aggiungeva: «La forza del vincolo nazionale, la potenza delle simpatie nazionali sono state rivelate in questa guerra dalla condotta, per esempio degli irlandesi in una delle due coalizioni imperialistiche e da quella dei cechi nell’altra. I capi consapevoli dell’imperialismo si dicono: naturalmente non possiamo realizzare i nostri disegni senza soffocare i piccoli popoli, ma vi sono due modi per strangolarli. In alcuni casi è più sicuro – e vantaggioso – guadagnarsi dei leali e coscienziosi «difensori della patria» nella guerra imperialistica, mediante la creazione di Stati politicamente indipendenti, della cui soggezione finanziaria saremo «noi» a prenderci cura! È più vantaggioso (in una grande guerra tra potenze imperialistiche) essere gli alleati della Bulgaria indipendente, anziché i signori dell’Irlanda asservita!» Lenin, Una svolta nella politica mondiale, gennaio 1917, Opere, Lotta comunista, 2002, vol. 23, p. 268. Nell’ambito della cosiddetta “sinistra rivoluzionaria”, esistono figure che, spesso per personali esigenze “identitarie”, non riescono ad accettare l’idea che una posizione coerentemente internazionalista possa avvalersi dell’elaborazione di Lenin. Tali figure, poste di fronte all’evidenza che una simile posizione esiste e che è di una solidità a tutta prova, puntano i piedi in preda ad un’irritazione direttamente proporzionale alla loro impotenza teorica, e ricordano malinconicamente quegli “esperti” di leggi fisiche – privi di qualsiasi nozione di cosa sia la dialettica – troppo impegnati a dimostrare che il bombo è «troppo pesante per volare» per accorgersi che il bombo vola, e vola alto.
[2] K. Marx, Grundrisse, Manifestolibri, Roma, 2012, pp. 55-56.
[3] Ne è un esempio significativo la Seconda guerra sino-giapponese del 1937-1945, che solamente dopo lo scoppio del conflitto fra grandi potenze nel 1939 è stato possibile definire come parte, se non l’inizio, della Seconda guerra mondiale.
[4] Dipendendo – tra le altre cose – dal grado di omogeneità dei livelli di consapevolezza e di forza politica del proletariato delle diverse nazionalità coinvolte, non è possibile stabilire in anticipo se questa soluzione rivoluzionaria si realizzerà come separazione statuale delle realtà nazionali riconosciute come tali, piuttosto che in una federazione o nella fusione in entità multinazionali, e pertanto non è possibile escludere aprioristicamente nessuna di queste opzioni, quantomeno come forma transitoria.
[5] K. Marx, Discorsi sulla Polonia, novembre 1847, K. Marx – F. Engels Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 19, vol. VI, p. 410.