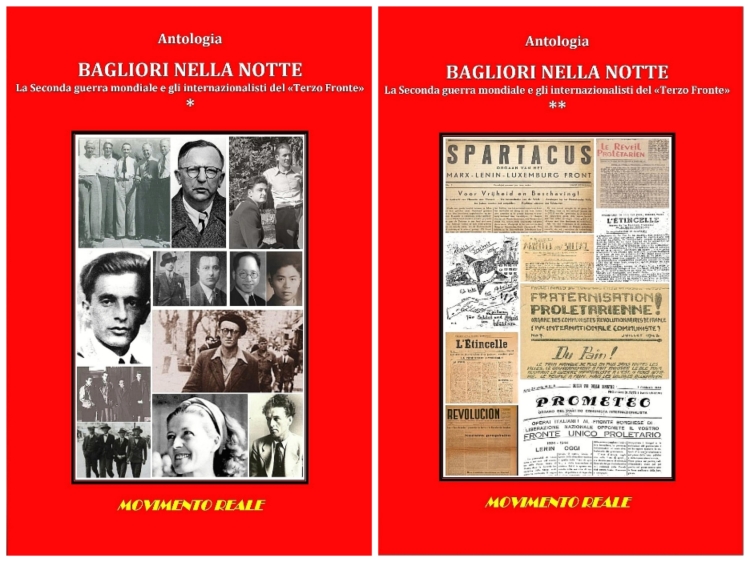
Dalla postfazione all’antologia Bagliori nella notte. La Seconda guerra mondiale e gli internazionalisti del «Terzo Fronte», Movimento Reale, luglio 2023. Articolo pubblicato nel n. 114 (novembre) della rivista Prospettiva Marxista.
XI
… siamo Germania anche noi, non solo quegli altri, e sarebbe un’idiozia totale se noi che siamo la Germania ci immolassimo per la Germania, cioè per noi stessi. Sarebbe come se un orso si tagliasse una chiappa e si mettesse a mangiarla in preda al dolore cercando di convincersi che deve sacrificarsi. Siegfried Lenz, Il disertore, 1952
Nel corso della Seconda guerra mondiale le poche realtà politiche autenticamente internazionaliste che si richiamavano all’esperienza bolscevica, pur non riuscendo a cogliere il significato più profondo del disfattismo rivoluzionario e dunque riproponendolo in forma astratta e schematica, seppero comunque rintracciare le radici di questa consegna nel riconoscimento della natura imperialistica della guerra. Una diversa e ben più grave critica riguarda tutte quelle formazioni che non avendo compreso a fondo il concetto di imperialismo giustificarono un loro preteso “superamento” della politica del disfattismo rivoluzionario mistificando la natura del conflitto.
Per i comunisti internazionalisti il disfattismo rivoluzionario non rappresenta un principio ma una delle possibili soluzioni tattiche per mezzo delle quali è possibile realizzare il principio della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile rivoluzionaria.
Una soluzione tattica, di per sé, non è applicabile in tutte le circostanze, o, perlomeno, non è sempre applicabile nella medesima forma, anche presupponendo che il problema di cui costituisce una possibile soluzione rimanga inalterato.
Le innegabili differenze esistenti tra il primo e il secondo conflitto mondiale potevano giustificare un abbandono del principio della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile? Oppure, da un punto di vista coerentemente marxista, il punto era adeguare la tattica alle mutate circostanze per raggiungere il medesimo scopo?
Ebbene, a nostro parere, il manifestarsi nel corso della Seconda guerra mondiale di quelle che Lenin chiamava “vittorie napoleoniche”, ovvero le repentine sconfitte di uno o più contendenti imperialisti con la conseguente occupazione del loro territorio, la sostituzione dell’apparato statale della borghesia sconfitta con l’amministrazione di una borghesia straniera o l’instaurazione di “governi fantoccio”, se poteva modificare la tattica per mezzo della quale raggiungere l’obiettivo della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile e l’abbattimento rivoluzionario dello Stato borghese, non poteva però, in alcun modo, mutare quell’obiettivo. Va da sé che quale che possa risultare lo strumento tattico più adeguato allo scopo della lotta contro la guerra imperialista, è assurdo pretendere che questa lotta possa passare per la giustificazione e la legittimazione “rivoluzionaria” della partecipazione del proletariato a quella stessa guerra, nell’uno o nell’altro schieramento. Per quanto elaborati e capziosi possano essere gli argomenti “teorici” di una simile presa di posizione, non si tratterebbe d’altro che di una rinuncia non dichiarata al perseguimento di quell’obiettivo.
Una delle condizioni affinché la parola d’ordine del disfattismo rivoluzionario non rimanga solo una testimonianza della fedeltà ad un principio ma possa trasformarsi in una tattica politica concreta è che il partito rivoluzionario rappresenti nelle file della classe operaia una forza in grado di renderle possibile approfittare delle sconfitte del proprio governo in guerra, prima della definitiva vittoria del suo nemico. Se questa forza è assente o viene a mancare, il dominio della borghesia “esterna” può integrare e/o sostituire quello della borghesia di casa propria. Quando l’esercito di uno Stato capitalistico viene sconfitto e il suo territorio viene occupato senza che la rivoluzione proletaria abbia avuto modo di realizzarsi, è evidente che, a rigor di termini, la parola d’ordine del disfattismo rivoluzionario si trova superata dagli eventi. La disfatta si è già verificata, ma il proletariato cosciente non è stato in grado di approfittarne prima che l’avversario della propria borghesia nella guerra imperialista prendesse il sopravvento, oppure, per tutta una serie di motivi, non ne ha avuto la possibilità.
Eppure, anche nel contesto di un’occupazione, la sostanza di un’autentica politica internazionalista non muta. Si tratta sempre di trasformare la guerra imperialista, per come si configura nelle condizioni di un’occupazione, in guerra civile rivoluzionaria.
La lotta rivoluzionaria del proletariato durante la guerra imperialista passa sempre attraverso la lotta contro lo Stato borghese in casa propria, che si tratti di quello della propria borghesia, di quello impiantato ex-novo dall’avversario imperialista della propria borghesia o di un governo “collaborazionista”.
In realtà, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l’amministrazione della potenza occupante, per quanto sbilanciata sulle esigenze della propria borghesia, deve pur sempre trovare una sintesi che rappresenti anche gli interessi capitalistici di quelle frazioni borghesi del paese occupato che sono maggiormente legate all’economia dell’invasore o che possono pervenire ad un compromesso accettabile con esso. D’altro canto, le frazioni borghesi escluse da questa sintesi, quelle “non collaborazioniste” o “resistenti”, rappresentano precisamente un altro Stato borghese in nuce.
È per questo motivo che la lotta rivoluzionaria del proletariato nelle condizioni di un’occupazione imperialista deve essere rivolta necessariamente anche contro le frazioni della propria borghesia escluse dalla rappresentanza nel nuovo Stato, uno Stato che vogliono rimpiazzare con il proprio mediante la prosecuzione della guerra imperialista con altri mezzi. La natura dei rapporti tra le minoranze internazionaliste e la “resistenza” organizzata non può non essere determinata da queste considerazioni.
Per la classe operaia cosciente che si pone come obiettivo quello di abbattere il dominio borghese, il nemico principale si trova sempre nel proprio paese. Questo assunto rimane valido anche qualora una borghesia imperialistica “esterna” imponga il proprio Stato nel paese sconfitto, e questo non tanto perché essa si sostituisca alla borghesia sconfitta quanto perché per il proletariato essa viene ad aggiungersi alla borghesia di casa propria, collaborazionista o meno. Di chi dovrebbe allora, la classe operaia del paese occupato, “augurarsi la disfatta”? La domanda non è banale. L’apparato statale dell’occupante è senza dubbio l’ostacolo che immediatamente si frappone tra il proletariato e la presa rivoluzionaria del potere, ergo, un suo indebolimento non può non costituire un vantaggio in tal senso e andrebbe favorito; tuttavia, favorire un simile risultato lottando contro l’occupante non implica nella maniera più assoluta la necessità di partecipare alla guerra imperialista, alla guerra che le frazioni borghesi spodestate di casa propria conducono a fianco delle potenze nemiche della potenza occupante, esattamente come il favorire la disfatta della propria borghesia nel corso della guerra imperialista non implica che tra i compiti degli internazionalisti ci sia quello di arruolarsi negli eserciti dei “nemici” di quella stessa borghesia o di collaborare con i loro Stati maggiori.
Le frazioni borghesi “resistenti” hanno indubbiamente il vantaggio ideologico della comune nazionalità con il proletariato del paese occupato, vantaggio che non possono mancare di far valere per coinvolgere il proletariato nella loro guerra, combattuta per i loro interessi, e per riempire immediatamente tutti gli spazi che la potenza occupante eventualmente in difficoltà sarebbe costretta a lasciare sguarniti. D’altronde, questo è esattamente quanto si è verificato verso la fine della Seconda guerra mondiale.
Come ha correttamente chiarito Arturo Peregalli, la “resistenza” organizzata all’invasore tedesco nei paesi occupati
non poteva essere giudicata fuori dal contesto generale della guerra imperialista, di cui era parte integrante. Il suo carattere progressista o reazionario non era determinato né dalla partecipazione delle masse né dai suoi obiettivi antifascisti e nemmeno dall’oppressione esercitata dall’imperialismo tedesco, bensì dalla natura reazionaria o progressista della guerra considerata nel suo complesso […] Partecipare al movimento della Resistenza, quali che fossero le parole d’ordine e le giustificazioni addotte, significava partecipare al conflitto mondiale e condividerne le finalità. Indipendentemente dall’atteggiamento delle masse e dalle intenzioni dei suoi dirigenti, essa rappresentava un’appendice, anzi, uno strumento del campo imperialista Alleato.[1]
Il proletariato dei paesi occupati si trovava dunque nella posizione di dover affrontare tre nemici: la potenza imperialistica occupante; la borghesia di casa propria – divisa tra collaborazionisti e “resistenti” – e le potenze imperialistiche contrapposte all’occupante. Il tutto, in una condizione che concedeva esilissimi margini di manovra.
Per le minoranze internazionaliste nei paesi occupati, la consegna da indicare al proletariato sulla via del raggiungimento della propria indipendenza di classe non poteva che essere quella dell’organizzazione della lotta di classe contro le conseguenze della guerra e contro la guerra stessa, la difesa fisica della classe operaia dalle violenze dell’occupante e dei suoi “governi fantoccio”, unita al rifiuto di ogni partecipazione ad operazioni militari subordinate esclusivamente agli obiettivi strategici dello schieramento imperialista contrapposto a quello dell’occupante.
Solo una simile politica internazionalista avrebbe potuto impedire che, di fronte al profilarsi della sconfitta della Germania, i proletari tedeschi in divisa si saldassero ancor più ai propri comandi e si incattivissero nei confronti del proletariato dei paesi occupati. Solo una politica internazionalista avrebbe permesso ai soldati tedeschi di riscontrare nei proletari polacchi, cechi, francesi, olandesi, belgi, danesi, norvegesi, jugoslavi, greci, ucraini, russi e italiani un’attitudine in stridente contrasto con le mistificazioni ideologiche con le quali erano stati indottrinati dalla propria borghesia. Solo una politica internazionalista avrebbe permesso ai soldati tedeschi di riconoscere nel proletariato dei paesi occupati un reparto della loro stessa classe, di distinguere nettamente questo proletariato dalla borghesia dei paesi occupati, da una borghesia che voleva vincere la guerra per i propri interessi instillando nel proletariato un odio antitedesco volto ad equiparare tutte le classi della società tedesca. Solo una politica internazionalista avrebbe permesso ai soldati tedeschi in ritirata di portare il bacillo del disfattismo anche in Germania.
Per raggiungere questi obiettivi concreti – e non per una qualche forma di sentimentalismo pacifista – era fondamentale intraprendere un lavoro politico pianificato di fraternizzazioni fra gli operai dei paesi occupati e i soldati dell’esercito occupante. Un proletariato educato alla coscienza internazionalista, operante in tal senso con una propaganda e un’agitazione clandestine efficaci, unitamente alla stretta contiguità determinata dall’occupazione, specie se prolungata, avrebbe potuto sviluppare un ambiente in grado di “contaminare” e “conquistare” consistenti nuclei di soldati dell’esercito conquistatore.
Circondati da un ambiente che non fosse loro pregiudizialmente ostile in quanto “tedeschi” e “stranieri”, raggiunti da materiale di propaganda esposto nella loro stessa lingua che denunciasse gli obiettivi imperialistici della loro borghesia e dei loro Stati Maggiori, avvicinati sistematicamente dagli operai rivoluzionari dei paesi occupati, sia che fossero in servizio sia che si trovassero in licenza, nelle caserme o nei luoghi di ritrovo, i soldati tedeschi avrebbero con ogni probabilità mostrato una minore “impermeabilità”, mentre maggiore sarebbe stata la difficoltà dei comandi e delle organizzazioni naziste nell’esercitare il proprio controllo politico sulle truppe.
Si sarebbero potuti coinvolgere i soldati tedeschi in organismi rivoluzionari di classe nei paesi occupati – più di quanto eroiche ma purtroppo microscopiche minoranze non siano riuscite effettivamente a fare – sviluppando in essi quella consapevolezza necessaria a costituirne di analoghi nel loro stesso paese.
Questo lavoro rivoluzionario avrebbe anche potuto rappresentare una soluzione al problema dell’armamento di classe, sottraendo alle frazioni borghesi “resistenti” e alle potenze Alleate lo strumento di pressione e ricatto rappresentato dalla fornitura di armi “selettiva” che garantiva il monopolio del loro possesso alle formazioni guerrigliere ad esse subordinate[2].
Invece, la risposta che le “resistenze” borghesi scelsero di dare alle violenze pianificate dai comandi dell’esercito occupante ed eseguite dalle sue truppe andava esattamente nella direzione contraria a qualsiasi opera di disgregazione dell’esercito occupante e a qualsiasi possibilità di fraternizzazione. La “scelta” non fu ovviamente casuale ma dettata da precise necessità e considerazioni politiche.
Pochissimi operai tedeschi in divisa da soldato – persino quelli stanchi e disgustati dalla guerra e da ciò che erano costretti a fare – si sarebbero arrischiati a tentare di fraternizzare o a disertare per passare nelle file di formazioni militari impegnate ad ucciderli indiscriminatamente per mezzo di agguati. Formazioni che, con ogni probabilità, non li avrebbero accolti come fratelli di classe ma come prigionieri, ammesso e non concesso che facessero prigionieri. Al contrario, proprio questa percezione di assenza di alternativa fece sì che, nella stragrande maggioranza dei casi, i soldati tedeschi si battessero con energia fino alla fine.
A questo riguardo, il numero di disertori tedeschi che passarono nelle file delle bande partigiane in Italia è altamente significativo. Da un lato, la limitatezza in termini assoluti di questo numero, oltre ad essere il risultato del rigido controllo e del feroce apparato punitivo della Wehrmacht, è anche il riflesso della scarsa disponibilità delle formazioni guerrigliere ad accogliere i disertori tedeschi e dell’estensione e profondità della percezione di ciò nelle truppe tedesche. Dall’altro lato, però, quello stesso numero è rilevante in termini relativi, in quanto espressione di una cospicua minoranza di soldati tedeschi che, riconquistata una prima forma di consapevolezza dell’essere stati usati come strumenti di una feroce politica imperialista, ebbe il coraggio – malgrado tutto – di gettarsi in bocca al lupo rischiando tutto pur di avere la possibilità di lottare armi alla mano contro la propria borghesia. Al verificarsi di questo fenomeno – oltre magari alla comune appartenenza politica dei disertori con quella delle varie guerriglie – non deve essere stata certo estranea la composizione sociale prevalentemente operaia della maggior parte delle formazioni partigiane, elemento che, nonostante la direzione politica borghese, deve aver comunque aperto dei varchi alla solidarietà di classe.
Si tratta in effetti di un fenomeno importante, che deve essere adeguatamente approfondito, indice di una disaffezione e di un disfattismo potenzialmente rivoluzionari che spinsero la classe operaia tedesca in uniforme a cercare il modo di combattere contro la propria borghesia nelle file di formazioni armate “straniere” con una forte presenza operaia. Tuttavia, nell’assenza di una prospettiva rivoluzionaria internazionalista e nella piena integrazione delle operazioni della “resistenza” nel quadro dei piani militari Alleati, il passaggio di disertori tedeschi nelle bande partigiane, per quanto espressione eroica dell’embrionale riacquisizione di una coscienza classista, non poteva assumere il carattere di una lotta condotta nell’interesse della propria classe ma semmai quello dell’oggettiva continuazione della partecipazione alla guerra imperialista, nei ranghi dello schieramento avversario a quello della propria borghesia. In conclusione, quella disaffezione e quel disfattismo – espressione di un malessere che si manifestò in mille altre forme con episodi di cui, per ovvi motivi, la borghesia tedesca e quella Alleata hanno lasciato solo una documentazione lacunosa e frammentaria – non furono raccolti da coerenti organismi di classe ma dagli schieramenti imperialistici contrapposti.
Fu un problema purtroppo tragicamente presente anche nella resistenza operaia interna alla Germania che, nella misura in cui si trovava sotto il controllo e la direzione stalinista, operò fondamentalmente come “quinta colonna” della potenza imperialistica russa. Non sempre combattere contro la propria nazione coincide con il combattere per la propria classe, quale che sia la percezione soggettiva.
Nelle condizioni estreme di un’occupazione imperialista la trasformazione della guerra in guerra civile rivoluzionaria incontrava dunque ostacoli enormi ed inediti. Le minoranze internazionaliste avrebbero dovuto operare in clandestinità contro occupanti, collaborazionisti, resistenze nazionali. Purtroppo, non è dato scegliere in quali condizioni condurre una politica internazionalista e, essendo i suoi compiti nettamente definiti, se si sceglie di condurla, si è obbligati a farlo nelle condizioni date. Oppure, si sceglie di condurre un’altra politica.
Durante la Seconda guerra mondiale le innegabilmente immani difficoltà non potevano modificare i compiti fondamentali dei comunisti rivoluzionari: l’organizzazione della lotta di classe per la difesa e il miglioramento delle condizioni di vita del proletariato durante la guerra, inseparabile dall’organizzazione politica indipendente del proletariato contro la guerra; l’organizzazione della difesa fisica della classe da violenze, vessazioni, coscrizioni obbligatorie, lavoro coatto o deportazioni; l’organizzazione del collegamento e della fraternizzazione con i proletari dell’esercito occupante e con i proletari nel paese dell’occupante con l’obiettivo della rivoluzione sociale.
Nelle condizioni di un’occupazione imperialista le rivendicazioni di classe conducono necessariamente ad un inasprimento dello scontro, fino al punto in cui la lotta di classe e la difesa fisica del proletariato arrivano ad esprimersi, in quanto tali, come lotta armata. Tuttavia, le diverse forme della lotta armata non sono equivalenti e possono esprimere un contenuto di classe altrettanto diverso. La lotta terroristica, propugnata e messa in atto dalle “resistenze” borghesi, nelle circostanze date non poteva far altro che rendere più difficili – se non impossibili – i compiti dei comunisti rivoluzionari. Una lotta armata di formazioni operaie che avesse rifiutato la pratica delle uccisioni indiscriminate di soldati stranieri – le quali, oltre a non portare a nessun risultato militare significativo conducevano invece direttamente al risultato politico perseguito dai socialsciovinisti: ovvero a rappresaglie sulla popolazione e all’inasprimento dell’odio reciproco –; una lotta armata di formazioni operaie che avesse rifiutato gli atti di sabotaggio miranti esclusivamente a favorire le operazioni belliche dello schieramento imperialista alleato della propria borghesia “resistenziale” e quelli privi di qualsiasi collegamento diretto con la difesa delle condizioni di esistenza della classe; una lotta armata di formazioni operaie che invece – sulla base delle concrete possibilità – si fossero prefisse di difendere la propria esistenza, di proteggere gli scioperanti, di rallentare la produzione, di cercare di impedire deportazioni, retate, razzie, pogrom, di distruggere archivi di polizia e liste anagrafiche, di liberare prigionieri o di impossessarsi di armi senza aspettare che venissero paracadutate dalle potenze nemiche dell’occupante, avrebbe rappresentato la sola lotta armata espressione di un’indipendenza di classe durante la guerra e l’occupazione imperialista, la sola lotta armata in grado di porsi eventualmente il problema della conquista del potere politico. Purtroppo, il lavoro necessario al raggiungimento di questi obiettivi non poteva essere improvvisato dall’oggi al domani e non poteva ritenersi assolto per mezzo della sola – indispensabile – salvaguardia teorica dei princìpi internazionalisti. Per porsi nelle condizioni di svolgere efficacemente il proprio ruolo, le minoranze internazionaliste avrebbero dovuto porre le basi di un loro efficace raccordo con la classe operaia molto tempo prima dello scoppio della guerra.
NOTE
[1] A. Peregalli, La natura della Seconda guerra mondiale e la dissidenza di sinistra, nel primo capitolo di questa antologia.
[2] In Italia, se il Comando supremo Alleato del Mediterraneo voleva limitare la quantità e la qualità degli armamenti da inviare ai partigiani per valutazioni politiche generali – non ultima il timore di armare elementi socialmente pericolosi – i comandi delle truppe Alleate direttamente impegnate sul territorio, al contrario, spingevano nella direzione opposta. Ciò avveniva non soltanto per considerazioni di carattere strettamente militare, ma anche perché i comandi in Italia erano molto più al corrente della situazione reale e conoscevano l’entità dell’influenza opportunista sulle formazioni partigiane e sulla classe operaia delle città, motivo per cui non erano eccessivamente preoccupate di armare le prime.

